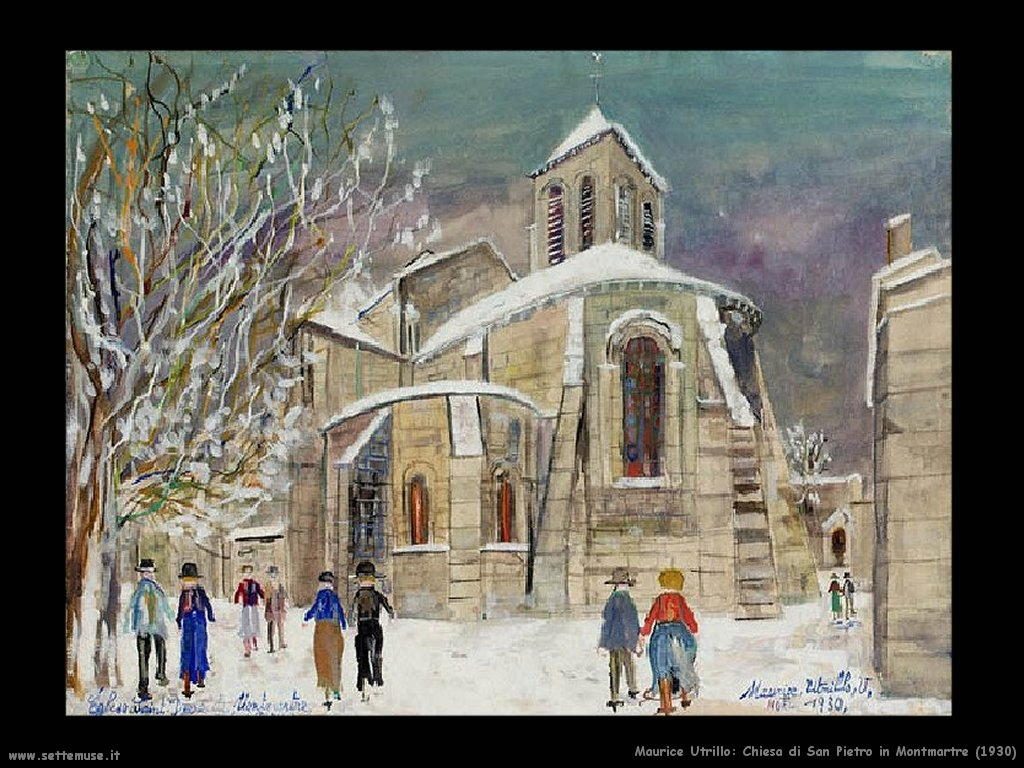di Anna Murabito
So che non ritornerò più a Istanbul. Ci sono stata tre volte. Sembra un numero magico, inventato, invece è proprio così.
Me ne tiene lontana un uomo che in un quieto pomeriggio domenicale ha gridato e inveito contro il nostro gruppetto di quattro italiani perché il Papa aveva pronunciato parole sgradite all’Islam. Me ne tiene lontana quel vento che nella vita si mette a soffiare in direzione contraria rispetto ai progetti.
Oggi Istanbul per me è solo nostalgia. Nostalgia degli occhi e di tutti i sensi. Non so se l’ho capita. Non pretendo di descriverla.
Lì ho visto il mare blu denso come la notte, quel mare che si confà alla terra e la circonda, con le scie, chiare sull’acqua, di vascelli che trasportano seta e zafferano.
È un mare che conosco, il mare della Grecia, il mare dello stretto di Messina, il mare di Omero e di Brassens (“intingi, intingi, mon tabellion, la tua penna nell’inchiostro blu del golfo del Leone”). Mito ed eternità. Spesso sudario: nei fondali è stato ritrovato ancora il vino negli orci di terracotta delle antiche imbarcazioni romane naufragate. Istanbul è adagiata su un mare così, con le sue immagini da cartolina turistica.
Eppure la prima volta che visitai la città furono altre le immagini che colpirono la mia fantasia. Un albergo di extra lusso, l’Hilton, una colazione degna di Sardanapalo, un favo di miele intero e un dolce orientale, la Helva o Halva, il cui nome andrebbe benissimo anche per una donna. La prima sera conobbi il fiume giallo, non quello cinese, ma quasi. Infiniti, i taxi scorrevano lungo i larghi viali di Barbaros, il quartiere residenziale del nostro albergo. Un flusso ipnotizzante e mutevole, visto attraverso le finestre di vetro a parete intera, bello come la fiamma del camino, con i fari che emergevano dall’asfalto nero. Lucciole mostruose e benefiche. La mente vuota. E una sorta di onirica confusione, forse era un film. La città mi era sembrata sterminata arrivando. Mai vista una uguale.
Un pessimo caffè turco nel pomeriggio, non sapevo che bisognasse aspettare prima di bere. E poi un negozietto primitivo in cui andammo a comprare l’acqua e qualche biscotto, il gruppo sarebbe arrivato l’indomani. Il padrone chiese a mio marito se io e la mia amica fossimo le sue mogli. Il suo orizzonte non oltrepassava il viale Barbaros.
Nei giorni che seguirono, Istanbul mi sembrò come una medusa, impossibile capire dov’è la testa, dove le appendici. Città disorientante e “tentacolare”, che però, pezzettino per pezzettino è a misura d’uomo, con qualcosa di intimo, quasi di provinciale, come nell’episodio del negozietto e in mille altre circostanze, tutte mansuete, e legate a un concetto di umanità che nulla ha a che vedere con la metropoli cinica e indifferente. Abitanti gentili. Ondate di profumi e allettamenti.
Giravamo sempre con il gruppo, con quel procedere strano e asfittico dovuto allo sforzo di adeguarsi a un ritmo innaturale. Abituata ai viaggi liberi con mio marito, al nostro vagare in tenda ovunque l’Europa ci avesse accolti, mi sentivo imprigionata. Mi limitavo a prendere appunti mentali con l’intenzione (prima ancora di aver visitato i monumenti) di tornare in quella città adagiata sul mare, piena di odori sensuali, colori mai visti, strade sconnesse e marciapiedi rotti. Una città che, come una canzone conosciuta, tornava nella mente pur non avendola mai imparata. La sera ci ripromettevamo di guardare i taxi, come chi si aspetta di sentirsi raccontare ancora la stessa favola.
Ricordo il freddo di quel primo viaggio, eravamo alla fine di marzo e c’erano zero gradi. E la vista dei tanti fedeli che fuori dalle moschee si lavavano i piedi con l’acqua gelata. Ricordo i cimiteri di pietra bianca, con la loro simbologia elementare, turbanti per gli uomini, rose per le donne. Amore per sempre nel silenzio? Chissà. Magari si odiavano. Istanbul alimenta favole e intrighi.
Ricordo la Cisterna, le grandi moschee e i profumi che prendono a tradimento. Topkapi e la Reggia di Dolmabahçe, adagiata sul Bosforo, gli specchi dorati e gli orologi fermi a celebrare l’ora della morte di Atatürk. Tutti gli itinerari turistici, insomma, e le sensazioni che avrebbero trovato conferma negli altri viaggi, con delle varianti tuttavia. Allora (anni ’90) Istanbul era ancora la città di Atatürk. E le ragazze circolavano in minigonna alle dieci di sera sul viale Barbaros. Oggi è la città di Erdogan. E non è più la stessa cosa.
Già quando ci sono ritornata in automobile era cambiata. Molte donne vestite di nero. Molte ragazze col velo, spavalde, quasi a rivendicare l’orgoglio della loro schiavitù. A chiamare tradizione l’assoggettamento.
La Turchia che abbiamo attraversato in macchina per arrivare a Istanbul venendo dalla Grecia, non era più Europa. Ore di fila alla dogana, dove nessuno parlava una dannata lingua straniera, strade deserte e sconnesse, nessun luogo di ristoro lungo il percorso. Ogni tanto una piccola città dal fascino distante emergeva dal mare, quasi sempre con l’impressione di trovarti in un altro mondo. Poi, a circa trenta chilometri dalla metropoli, la musica cambiava: traffico pesante in autostrada, quattro corsie in un direzione quattro nell’altra e un inferno di automobili, autocarri, autobus, uno strepito esagerato, cannibalesco. Il fiato del drago arrivava lontano.
Arrivammo in una città che ci apparve non solo sterminata (questo lo sapevamo) ma nemica: vie senza nome, porte senza numeri, buche, terribili salite e discese, un temporale violentissimo, le strade scorrevano, gli oggetti galleggiavano. Vicoli da cui era difficile uscire, uomini con carichi sulle spalle più degni di una gru. E only turkish only turkish only turkish, l’unica lingua parlata, l’unica lingua che non ci serviva, l’unica risposta che non ci serviva.
Il padrone dell’albergo, in cui alla fine arrivammo lieti di aver salvato la pelle, ci requisì perentoriamente le chiavi della macchina e pretese di guidare lui fino al parcheggio, maltrattando le marce della mia Punto. Non potevamo più spostarla, ci disse. Quello era il posto della nostra automobile per tutti gli otto giorni di permanenza. Se l’avessimo abbandonato per un momento non l’avremmo più ritrovato. Mi sembrò un cattivo inizio, ma poi arrivammo nella stanza e trovammo un ambiente intimo e pulitissimo, con una grazia antica, incantevole. Si chiamava Orient Express, l’albergo, e il nome mi aveva ispirato timori. “Dove mi stai mandando?”, avevo chiesto ironicamente alla nostra agente di viaggio. “Stai tranquilla”.
Un soggiorno felice, Bejoglu, Sirkeci, nomi cari alla mia memoria, sembrava un quartiere di pochi metri quadrati e invece erano chilometri quadrati. Una stradina profumata dalle delizie preparate in un panificio poco distante, una ragazza in vetrina che annodava tappeti di seta, un agente di cambio. Un ambiente primo Novecento, le meravigliose ciambelle col sesamo della prima colazione, i dolci alle mandorle, il caffè che avevo imparato a bere. E un paesaggio di antichi palazzi con un gabbiano di pietra su un comignolo. Mi incantavo a guardarlo dalla nostra stanza, strano soggetto. Finché una sera tornando “a casa” non lo vedemmo. Era volato via, aveva trovato la sua anima ed era partito per un’altra vita.
La mitica stazione dell’Orient Express, così vicina al nostro albergo, era più antica e più buia di come l’avevo immaginata, con una finestra dai vetri colorati da cui filtrava una luce speziata. Un’atmosfera estatica. Un uomo fermo in una posa da dipinto, forse assopito. Come quei vecchi immobili con gli occhi perduti nel loro corto avvenire che sembrano aspettare un evento che non si compirà mai. Ma quell’uomo non era vecchio. Forse non esisteva, o forse sì: Istanbul alimenta visioni. Comunque so di averlo fotografato, non vaneggio.
Ora la città era nostra e cominciavo a comprenderla più di quella prima volta. La sentivo nel suo ritmo profondo, la sentivo brulicare. Lontana da quell’andare scomposto ed affannato di folle pezzenti, Istanbul brulica naturalmente e nobilmente nelle cose e nella storia, nei taxi avventurosi, nei sapori che riscaldano la gola, nel caleidoscopio delle spezie, nell’afrore che sembra levarsi ancora dalle stanze delle concubine.
Vagavamo, in questa città immaginaria e onirica, e chiedevamo, da poveri europei legati ai loro schemi, una mappa con il percorso degli autobus, ma nessuno ci capiva. Né i bigliettai, né gli operatori dei traghetti né gli impiegati dell’Ufficio del Turismo. Un direttore delle Poste ci ricevette con ogni onore, ma no, no, non capiva cosa chiedessero questi turisti, forse perché a Istanbul la mappa che chiedevamo noi non esisteva. Ma che importava? Usciti dall’Ufficio Postale ci accolse un sole glorioso nell’aria sempre frizzante della città e una vecchia donna distribuiva il mangime alle tortore e ai colombi mentre dal vicino Bazar delle Spezie fuoriuscivano effluvi mai sentiti.
Avidi, inventammo un itinerario e percorremmo con un autobus strade comuni fuori dal centro urbano. Arrivammo in zone “vicine” all’integralismo, vedemmo ragazzini giocare su strade sterrate e rigagnoli d’acqua, forse fogne a cielo aperto. Così avevo immaginato qualche quartiere degradato di Rio de Janeiro. Perché non scendete, ci chiese a gesti l’autista, facendoci capire che “fine”, era il capolinea. “Tourism”, rispondemmo, sperando che almeno quella parola la capisse. La capì. “Tourism! Tourism!”, non finiva di ridere. Ma noi contavamo i giorni che ci separavano dalla partenza, perché non volevamo che arrivasse troppo presto.
Molte volte abbiamo attraversato a piedi, sempre nel sole, il ponte di Galata, e sempre abbiamo visto pescatori con lenze lunghissime, immobili. Qualche volte ho pensato che i pescatori fossero sagome e i pesciolini finti. Ma poi ho visitato i banchi delle taverne sotto il ponte e sentito il profumo delle fritturine che venivano approntate e offerte ai passanti nei cartocci. Pesciolini veri. Pesciolini d’oro?
Tutte le donne ormai vestivano di nero e anche i giovani uomini. Il sabato pomeriggio era impossibile camminare senza temere di essere sommersi da un’onda a lutto. L’illuminazione della città era stata migliorata e la sera una sorta di magia appagava la vista.
Recuperammo l’automobile dopo gli ultimi giri nostalgici, con negli occhi il blu del mare e della Moschea designata con lo stesso colore. Comprammo le ultime ciambelle al sesamo. Vicini al confine con la Grecia fummo fermati per un controllo. Ma non fu un controllo, fu una catastrofe, fu la bocca amara, l’incursione della realtà e la promessa fatta a noi stessi che mai saremmo tornati in Turchia in automobile. Dopo una lunghissima attesa, ci invitarono a scaricare l’automobile. Noi avevamo fatto tutto il viaggio in tenda tranne la sosta a Istanbul prevista in albergo, e la nostra macchina era la nostra casa, con tutto disposto secondo un criterio, un’infinità di oggetti da trovare anche a occhi chiusi, i sacchi a pelo, le vettovaglie, gli asciugamani, ciascuno col suo scomparto. Cominciammo a scaricare mettendo tutto per terra su un marciapiede e alla fine l’impiegato ci dette una mano perché era un’operazione faticosa e gli facemmo pena. Sollevarono l’automobile come quando si fa il cambio dell’olio, poi la passarono a lungo sotto un bombardamento di raggi x e, solo dopo aver constatato che non avevamo rubato nessun reperto archeologico, ci lasciarono andare con tutto il nostro carico violato da risistemare. Tre ore? Una mattinata. Con una sorta di rabbia sorda, e le ciambelline andate in malora perché rimaste, unico oggetto, nell’abitacolo dell’automobile e ora probabilmente contaminate di radioattività. Le buttai come ci si butta alle spalle un addio. E subito dopo il confine di nuovo improvvisamente Europa, comprese le nenie greche che giudicavo insopportabili e i dolci stucchevoli e appiccicosi, ma venduti al supermercato.
Non posso dire di aver capito bene questa città. Né geograficamente (ogni volta che guardo la cartina, vedo dov’è il Bosforo e dov’è il Corno d’oro, ma poi lo dimentico) né intellettualmente. L’affascinante Gran Bazar, per esempio, ospita una specie non umana, quella dei commercianti puri. Lì si vende e si compra il mondo intero, dal tappeto pregiato alla paccottiglia di plastica, dalle montagne di spezie di tutti i colori agli oggetti di antiquariato e alle stampe antiche, fino alle scarpe da ginnastica per i ragazzi. In una città in cui non si parla nessuna lingua, lì si parlano tutte le lingue e si possono imbastire anche lunghe conversazioni stereotipate. La parola amico è abusata. E i vassoi di the alla mela che vanno e vengono non sono espressione della gentilezza orientale ma pura tecnica di vendita.
Mi dispiace non aver incrociato lo sguardo di nessuno. Solo una volta una ragazzina ci rincorse da un negozietto con in mano un paio di cucchiaini di plastica: come avremmo fatto, sennò, a mangiare lo yogurt? E i suoi occhi erano “ridenti e fuggitivi” come quelli di un’altra fanciulla di qualche anno meno giovane, di molto tempo fa.
Poi, durante l’ultimo viaggio, ho incrociato lo sguardo di una giovane donna turca, di nome Gül, che significa rosa. Anzi ho parlato a lungo con lei. Il mio terzo viaggio in Turchia fu ancora un viaggio organizzato, un indimenticabile giro dei siti archeologici dell’Anatolia tra cui Pergamo (l’Ara è oggi interamente ricostruita in un museo di Berlino). Il giro includeva anche Istanbul e allungammo un po’ il soggiorno per consentire a un’amica che non conosceva la città di raggiungerci. Gül era la nostra guida. Con un corpo agile ed elastico, si inerpicava a velocità per strade antiche che ci affaticavano, si fermava a raccogliere pistacchi insipidi e ce li offriva, nel cavo della mano. Era stata tre anni in centro Italia, dove aveva studiato e aveva degli amici che l’avevano implorata di non tornare in Turchia. Amava un uomo. Sposato. Per questo era tornata. “Sei pazza”, le dissi, “non lascerà mai la moglie”. “Ma lui…” “Sei pazza, torna in Italia”. “Non so se mi lasciano tornare”. Un’altra moglie, la moglie di Erdogan si era già mostrata in pubblico col velo e in atteggiamento dimesso, come si conviene a una vera donna islamica. Non ho saputo più nulla di Gül. “Capisco l’Europa che non ci vuole”, diceva.
Quella volta sapevamo a memoria certi ambienti e certe strade e sbalordimmo la guida, non Gül, un giovane uomo, quando, stanchi di vedere per la terza volta la famosa Cisterna, gli dicemmo che eravamo in grado di tornare in albergo da soli. “Conoscete Istanbul così bene? Ma è un’ora di strada, forse più”. L’avremmo fatta. Traversammo il Ponte di Galata, ritrovammo una via lunghissima e stretta che sale terribilmente o scende secondo la direzione di marcia. Piccoli negozi, ferramenta, gommisti, idraulici, elettrauto, uomini-muli, buche-attentati, attrezzi segosi e strepito. Quando arrivammo finalmente alla stazione del vecchio tram, trovammo l’inizio della famosa Istiklal, almeno pianeggiante e dritta. Quest’arteria così nota non ha nulla, non dico degli Champs-Élysées o della Unter der Linden, ma neanche dei tanti anonimi viali alberati delle città europee. È una strada provinciale e non caratterizzata in cui continua, appena più elegante, il fervore commerciale della città. Nient’altro. Solo qualche locale d’atmosfera, mai buona musica.
Molte volte mi sono imbarcata sui tanti traghetti, ho guardato i profili delle moschee e i palazzi antichi sull’acqua che, non so perché, mi toccavano il cuore. Non ci sono nella città capolavori d’arte che si impongono al primo sguardo. Mai penserei alla musica di Mozart pensando a Istanbul. Istanbul non è limpida, è vaseuse, come dicono i francesi, torbida, indistinta come la nostalgia di una vita che finisce nel momento stesso in cui la si vive. Soprattutto nei tramonti quando il sole si perde in pulviscolo dorato, e diventa respiro, diventa agonia. Venezia celebra la morte, ogni giorno. Istanbul celebra il languore e l’estenuazione. Musset, malato, scoraggiato e tradito da George Sand, scrisse che i veneziani “vanno in barca su delle fogne dentro sarcofagi neri”. Per Istanbul bisognerebbe inventare una poesia che celebri l’oro e l’ocra delle sue atmosfere. Ma non conosco i poeti di Istanbul. Venezia è interamente europea, pagana, coerente, raffinata, invade gli occhi con la sua arte “estrema”. Istanbul è orientale, sovrabbondante, mercantile e tuttavia ardente di una sorta di misticismo sragionante e altero che grida nelle disperate geometrie delle sue maioliche.
Come per Morte a Venezia le note dell’Adagietto hanno accompagnato le scene del film, così penso ancora a Mahler per Istanbul, più che a Sheherazade. Non è tutta favola, questa città. È vero, una volta, l’ultima, l’ho vista dalla terrazza del nostro albergo e assomigliava proprio alla favola classica con il cielo che regala al mare il velluto, con le imbarcazioni col gran pavese e le luci “in capo ai minareti”.
Se dovessi definire Istanbul, direi che è una favola sterminata e ambigua che annega ogni giorno con il suo stridore. Ecco perché Mahler mi sembra adatto ad accompagnare il mio ricordo, quel Mahler che non trova una composizione tra passato e presente, ma a volte li giustappone dolorosamente.
Eravamo ancora una volta sul traghetto, la classica gita sul Bosforo, quando la mia amica che ci aveva raggiunti esclamò: “Eccoti. Quaranta chili di passione, ci hai trascinati tutti qui”. Guardavo i palazzi. E, non è un finale melenso e scontato, “sapevo” che non ci sarei più tornata.